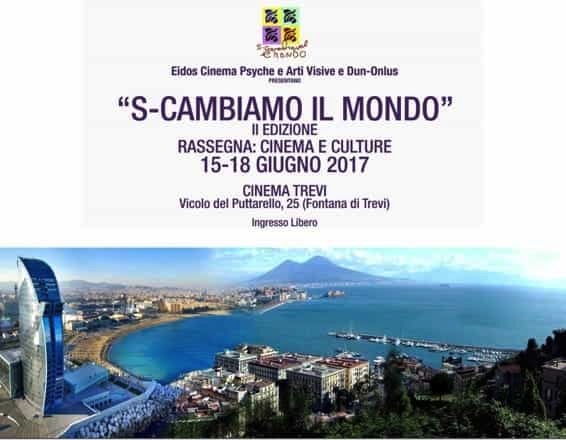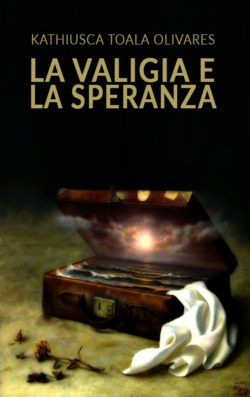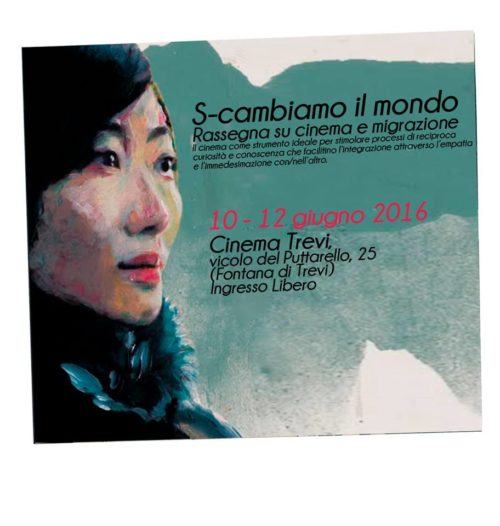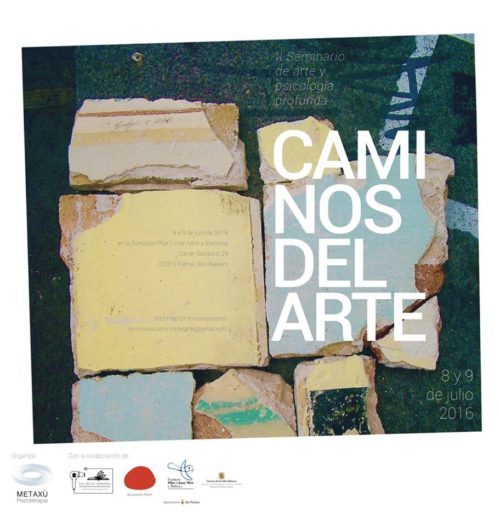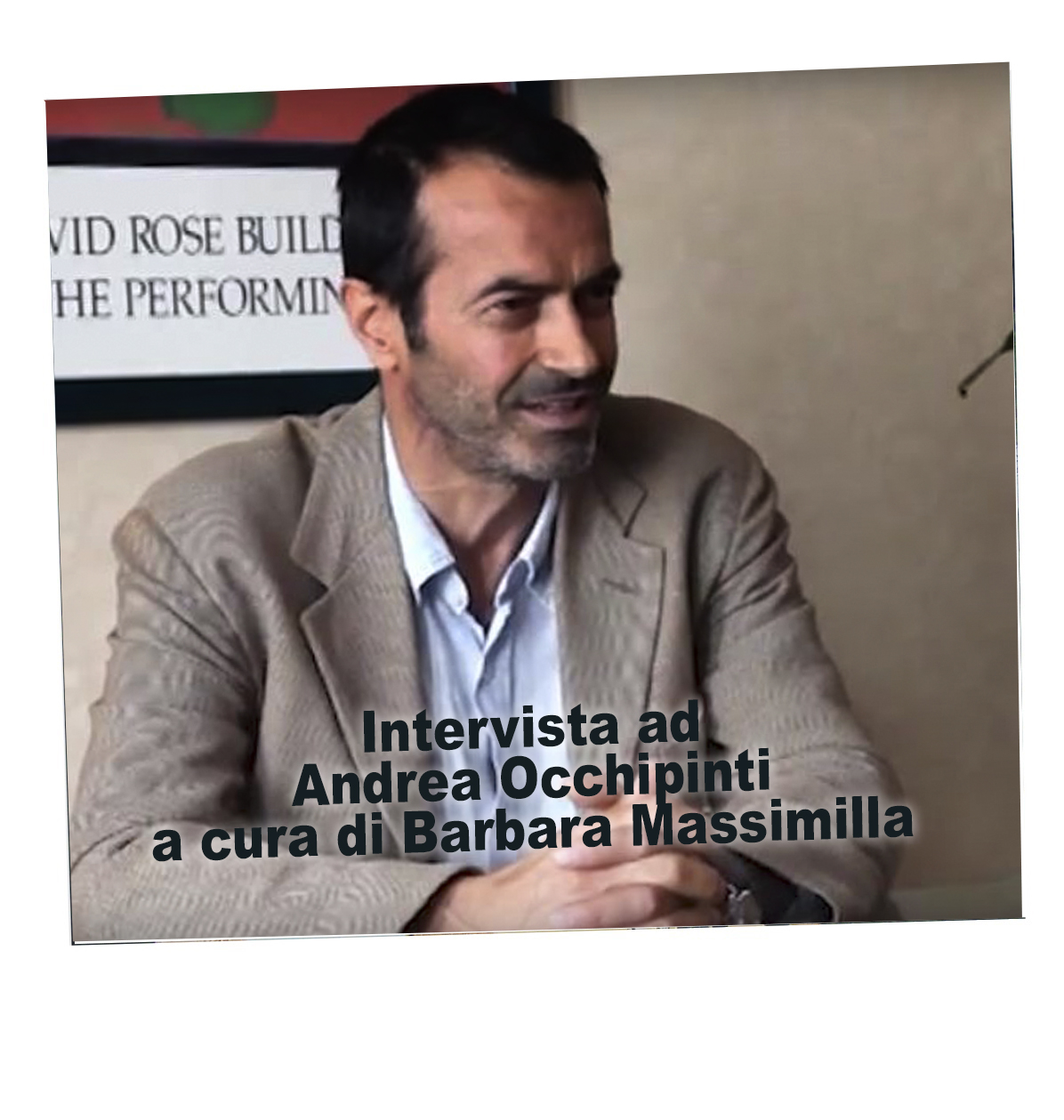La rassegna organizzata da DUN-Onlus, associazione dedicata alle cure psicologiche ai migranti, in collaborazione con la rivista “Eidos cinema psyche e arti visive” e il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, nella terza edizione continua la sua ricerca sul tema dell’intercultura attraverso il cinema. Patrocinata da: Amnesty International Italia, Regione Lazio, Associazione Italiana Psicologia Analitica. Realizzata con il sostegno della Fondazione Migrantes e della Cooperativa Sociale META. Quattro sezioni monotematiche coinvolgeranno il pubblico di diverse nazionalità, nella condivisione del cinema d’autore centrato sulle narrazioni culturali e sul diritto a migrare. Si vuole spingere lo sguardo oltre ‘il dovere’ che come occidentali proviamo nel prendere atto del diritto fondamentale dei popoli a migrare per molteplici e legittime motivazioni, poiché il fenomeno migratorio è costitutivo e strutturale della nostra identità di specie. E’ necessario coltivare eticamente l’uguaglianza che ci legittima tutti a riconoscerci sullo stesso piano, in base all’identità etnica e geografica di ogni essere umano. Vogliamo precorrere i tempi in termini di speranza, spostare l’asse dalla migrazione al valore della ‘coesistenza’ tra le culture e i popoli, per scoprire le loro realtà anche attraverso il cinema, per apprezzare la bellezza dell’incontro con altri mondi, per S-cambiarci i Mondi, ciascuno partendo dalle proprie origini.
Programma a cura di Barbara Massimilla.
Giovedì 7
Nuove Identità
ore 17,00 Presentazione della rassegna a cura di Barbara Massimilla
a seguire
Il segreto di Hamida di Cristina Mantis(2017, 11’)
L’incontro con il mondo occidentale visto attraverso lo sguardo spontaneo e saggio di una ragazza del Bangladesh che si sta affacciando all’adolescenza, chiamata a confrontarsi con l’esperienza, non priva di ambivalenze e difficoltà, del suo primo giorno di scuola in Italia, il Paese dove è appena arrivata con la famiglia. Nel tentativo di superare la dicotomia tra assimilazione ed emarginazione, Hamida trova un’illuminante terza via ispirandosi a una chiocciola, la quale, ovunque vada, porta sempre la propria casa con sé. Da questa suggestione la ragazza ricava una possibilità trasformativa in grado di ricomporre realtà apparentemente inconciliabili, senza tradire la propria identità femminile e culturale.
ore 17,30 The Immigrant di Charlie Chaplin (1917, 25’)
Tra i cortometraggi di Chaplin è uno dei più elaborati e quello più amato dall’autore, che vi riflette in chiave comica molte delle sue peripezie di giovane artista di vaudeville inglese immigrato negli Stati Uniti. I sempre attuali disagi degli immigranti ammassati in trasporti di fortuna e trattati con fredda diffidenza dalle autorità sono rappresentati con quell’intuizione comica e umana che spingerà Henri Michaux a definire Chaplin “attore dell’inconscio”. In questo equilibrio tra umorismo e poesia, è evidentemente autobiografico il ritratto ottimista e romantico del protagonista, un artista squattrinato che alla fine trova un modesto ingaggio e una compagna. Di questo cortometraggio Chaplin scriverà: “The Immigrant mi ha emozionato più di ogni altro mio film. Penso che il finale abbia un tocco davvero poetico”.
ore 18,00 Almanya – La mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli (2011, 101’)
Storia di una famiglia di origine turca stabilitasi in Germania da tre generazioni e che torna in Turchia per trascorrere l’estate in una casa acquistata dallo stesso nonno ormai in pensione. Al viaggio “di ritorno” fa da contrappunto la narrazione di quello affrontato a suo tempo dai nonni emigranti in Germania, ricco di speranze e difficoltà, raccontato dalla nipote Canan, segretamente incinta, al cuginetto Cenk. Il sentimento di appartenenza ed estraneità ai due paesi, diversamente avvertito da giovani e anziani, attraversa l’intera famiglia che, nell’esperienza del viaggio attuale e di quello narrato, trova in se stessa una più forte coesione e identità.
ore 19,45 Incontro moderato da Barbara Massimilla con Antonella Antonetti, Massimo Germani, Andrea Magnani, Nicola Nocella, Emanuela Pasquarelli, Maria Rita Porfiri
ore 21,15 Easy – Un viaggio facile facile di Andrea Magnani (2017, 91’)
Un singolare film “on the road”, che attraverso gli occhi di un insolito protagonista racconta molto dell’opportunismo e del cinismo con cui i lavoratori immigrati sono a volte trattati in Italia. Easy infatti è Isidoro, un giovane ex-pilota di kart che si è progressivamente ritratto e isolato dalla realtà, mentre il fratello è un imprenditore edile che gli chiede di riportare clandestinamente in patria il corpo di Taras, un lavoratore “in nero” ucraino morto nel suo cantiere. Comincia così un viaggio che dovrebbe essere, appunto, “facile facile”, nel corso del quale al candore di Easy fa da contraltare prima l’Italia dello sfruttamento e dell’abusivismo, e poi, in un rocambolesco susseguirsi di surreali peripezie, un’Europa dell’Est aspra e primordiale, nella quale Easy scoprirà sempre più a fondo la vita di Taras. Premiato a Locarno Festival.
Venerdì 8
Culture ed Echi del Femminile
ore 17,00 Hope di Boris Lojkine (2014, 91’)
Leonard è un giovane camerunense che ha abbandonato il suo paese con il sogno di raggiungere l’Europa, trovare un lavoro e mandare aiuti alla famiglia. Lungo il suo itinerario incontra Hope una ragazza nigeriana travestita da uomo, disposta a tutto pur di salvarsi. Nel corso del viaggio tra i due si instaura un rapporto utilitaristico in cui ciascuno è indispensabile all’altro. Hope si prostituisce procurando denaro per pagare le tappe di un itinerario controllato dalle mafie locali e tra meccanismi spietati e regole feroci si innamora di Leonard mentre il ragazzo camerunense pensa unicamente al suo obiettivo. Solo nel finale i sentimenti più autentici potranno svelarsi. versione originale con sottotitoli in inglese
ore 19,00 Incontro moderato da Barbara Massimilla con Mariella Cortese, Patrizia Di Gioia, Andrea Occhipinti, Sabina Traversa
ore 21,00 Mustang di Deniz Gamze Ergüven (2015, 97’)
Lale, Nur, Ece, Selma e Sonay sono cinque giovani sorelle che vivono in un villaggio costiero della Turchia. Insieme partecipano alla festa di addio dell’insegnante di Lale, la più giovane. Al termine dei festeggiamenti le ragazze si uniscono a un gruppo di studenti maschi in spiaggia e lì si abbandonano a giochi in acqua, completamente vestite, dimentiche di ruoli e di regole. La notizia dello scandalo arriva alle orecchie della nonna e dello zio che le segregano in casa, cercando poi di soffocare lo scandalo attraverso matrimoni riparatori. Con tutte le loro forze e a carissimo prezzo le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, proprio come i cavalli ‘Mustang’, si ribelleranno alle costrizioni imposte.
Sabato 9
Confini e difficili Coesistenze
ore 17,00 Il giardino dei limoni di Eran Riklis (2008, 106’)
Salma è palestinese e vive da sola in Cisgiordania, a due passi dal confine israeliano. La sua unica preoccupazione, con un figlio in America e il marito in cielo, è il suo giardino di limoni, ereditato dalla famiglia e fonte del suo sostentamento. Peccato che il suo nuovo vicino di casa sia il primo Ministro della Difesa israeliano che vede negli alberi di Salma una possibile schermatura a potenziali attacchi terroristici e quindi ne ordina lo sradicamento. Salma inizierà una battaglia legale infinita, sostenuta dal giovane avvocato Ziad e a distanza da Mira, la moglie del ministro che la osserva oltre il recinto. Entrambe le donne soffrono e si scoprono simili e solidali. Ma Salma sarà vittima di un potere troppo forte e più grande di lei. Un film che esplora barriere fisiche e spirituali di un conflitto senza fine.
ore 19,00 Incontro moderato da Barbara Massimilla con Alfredo Ancora, Andrea Arrighi, Giovanni De Robertis, Carla Dugo, Clementina Pavoni
ore 21,00 L’insulto di Ziad Doueiri (2017, 112’)
Beirut. Durante i lavori di restauro della facciata di un edificio, Yasser, rifugiato palestinese, capocantiere attento e scrupoloso, vorrebbe intervenire sull’impianto idraulico esterno di un appartamento. Toni, il proprietario, un cristiano libanese militante, meccanico di professione, lo aggredisce, demolendo la riparazione del tubo rotto. La lite si conclude con un insulto che Yasser lancia a Toni. Quest’ultimo, ferito nella sua dignità, decide di denunciarlo. Una questione privata che gradualmente, con il sostegno di uno studio legale importante scelto da Toni, diventa un processo di dimensioni nazionali seguito da tutta l’opinione pubblica. Lo specchio di una divisione antica e sempre presente nel paese che fa riaffiorare ferite profonde e mai sanate.
Domenica 10
Diritto al viaggio
ore 11,00 – Largo Cristina di Svezia
Concerto gratuito di pianoforte di Elizabeth Sombart
presso Associazione Résonnance Italia
ore 16,30 – Sala Trevi
Es I tempo di Djemberem di Cinzia D’Auria (2009, 17’)
Documentario ideato da un gruppo di artisti della Guinea Bissau. Il progetto è nato per sensibilizzare su temi scottanti del continente africano come guerra civile, colonizzazione, leadership, schiavitù, utilizzando la musica come potente strumento evocativo e “risuonante” che sostituisca al frastuono assordante e mortifero della guerra il suono dolce e armonioso della pace.
ore 17,00 L’ordine delle cose di Andrea Segre (2017, 112’)
Corrado è un funzionario del Ministero degli Interni italiano che lavora contro l’immigrazione clandestina. Il suo lavoro non è facile, cercando di mantenersi sempre in equilibrio, di mettere insieme la realtà libica con gli interessi europei, un compromesso che risulta spesso impossibile. Un giorno conosce Swada, una donna somala che sta cercando di fuggire dalla detenzione libica per raggiungere il marito in Europa. L’equilibrio di Corrado vacilla ancora di più: come tenere insieme la legge e il suo lavoro con l’impulso “umano” ad aiutare un altro individuo in difficoltà?
ore 19,00 Incontro moderato da Barbara Massimilla con Stefano Carta, Cinzia D’Auria, Filomeno Lopes, Giuseppe Riefolo, Andrea Segre
ore 20,00 Human di Yann Arthus-Bertrand (2016, 134’)
Il documentario straordinario e commovente di un grande fotografo e regista francese che si interroga sul senso della vita e dell’Umano. Attraverso diverse voci e con il potere delle immagini e delle parole, dialoga sulle questioni fondamentali dell’esistenza, trasmettendo la bellezza del nostro “essere nel mondo” che tocca le corde più profonde di noi stessi facendoci sentire la possibilità di essere tutti intimamente connessi.